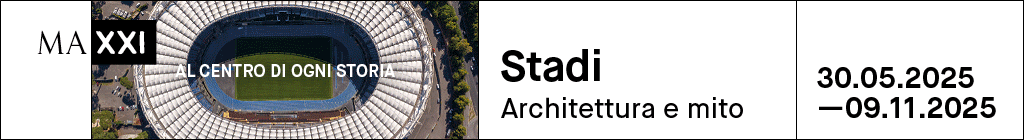Se l’intelligenza artificiale progetta meglio degli architetti
La professione non è finita, ma deve evolversi e cambiare, capire che la vera sfida non è competere con le macchine, ma ridefinire il senso stesso del lavoro che si svolge
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELL’ INCHIESTA
Published 10 settembre 2025 – © riproduzione riservata
Non ero niente.
Non sono niente.
Non sarò niente.
A parte ciò,
ho dentro di me
tutti i sogni di questo mondo!
Ferdinando Pessoa
Il dibattito tra architetti – e non solo – sull’intelligenza artificiale normalmente si fossilizza sul classico bipolarismo conflittuale tra nerd-sostenitori e luddisti-detrattori. Una dialettica già vista molte volte storicamente, ogni volta che è stata introdotta un’innovazione tecnologica.
Lo scontro è irrilevante. Ma anche pericoloso. Perché distrae e non permette di cogliere una frattura ben più importante; una soluzione di continuità che potrebbe essere devastante per la categoria dei professionisti della progettazione.
Sostengo, cioè, una tesi ben precisa e diversa dal dibattito mainstream: le intelligenze artificiali progettano meglio degli architetti! Non solo. Sfatano un tabù che sembrava inviolabile, ossia l’esistenza di una risorsa riservata esclusivamente al genere umano e non replicabile dalle macchine: la creatività.
Dall’arrivo pubblico, nel novembre 2023, dei modelli di intelligenza artificiale generativa (LLM), infatti, gli architetti e gli urbanisti non solo sono sempre più marginali nei processi di trasformazione urbana e dell’abitare – così come nella definizione di scopo e di senso delle comunità locali – ma non sono nemmeno più i detentori assoluti della sfera creativa, della produzione di stile e di cultura dei luoghi della vita e del lavoro degli abitanti delle città.
Ecco il senso della mia tesi. Se architettura oggi è prevalentemente “estetica funzionale” o “personal branding” instagrammabile, allora le IA sanno progettare meglio: senza egocentrismo, più velocemente e con minor costi. Con soluzioni a cui la creatività umana non può giungere perché il capitale di conoscenze e competenze della IA è superiore, aggiornato, non pregiudicato da orgogli personali. E, paradossalmente, rendono fattibile la partecipazione alla progettazione anche di milioni di abitanti, essendo accessibile ogni informazione, in qualunque lingua, in qualunque momento, in qualunque luogo del mondo, senza orari o pause. Senza costi aggiuntivi. Impossibile per l’essere umano.
Nello specifico, se oggi progettare l’architettura vuol dire, di fatto, focalizzarsi sugli aspetti estetico-funzionali, sempre più ammantati di soggettività da personal branding per le archistar, allora le intelligenze artificiali sanno progettare meglio. Le IA sono più brave soprattutto se lo scopo primario del progettista è quello di rendere “accettabili” le scelte degli interessi immobiliari, nascondendo il senso reale della trasformazione urbana dietro florilegi intellettuali incomprensibili. Anche in questo caso, allora, le intelligenze artificiali lo sanno fare meglio e in minor tempo.
Ancora, se il ruolo degli architetti e degli urbanisti è oggi quello di contribuire ad accentuare la polarizzazione conflittuale dei centri storici e delle periferie, rendendo i primi dei veri e propri “parchi a tema” e le seconde dei semplici “dormitori”, allora le intelligenze artificiali lo sanno fare meglio e con una maggiore efficienza economica e capacità creativa.
Ma, ancor peggio, se il senso etico e sociale dei costruttori di luoghi è indifferente al fatto di lavorare per una dittatura o una tirannia religiosa, piuttosto che difendere una democrazia – seppur incompleta e in profonda crisi – allora le intelligenze artificiali operano meglio e senza rimorsi. Non hanno codice etico.
Se, infine, lo scopo ultimo degli architetti e degli urbanisti è indifferente alla centralità del benessere reale dell’individuo, della sua collettività identitaria, del genere umano e del suo ecosistema biologico in generale, allora le intelligenze artificiali sanno andare ben oltre l’agire umano e finalizzare molto meglio ciò che progettano. Sono macchine e perciò indifferenti al senso di chi abita o vive nei luoghi in trasformazione.
Siamo arrivati alla fine della professione?
L’intelligenza artificiale ha dunque decretato la fine della professione dell’architetto e dell’urbanista? No, non credo proprio. Se mai ha solo accelerato un processo di decadimento innescato oramai da tempo, di marginalità di ruolo e di mera creazione brandizzata di processi gestiti da altri soggetti.
L’intelligenza artificiale è dunque la killer-app di architetti e urbanisti? Si e no.
La risposta – ossia il dibattito, il confronto – dovrebbe essere concentrata su questa riflessione di prospettiva e di senso: cosa vuol dire essere architetti nell’era delle intelligenze artificiali? Cosa vogliamo fare, essere, divenire? Visto che non possiamo competere con una macchina proprio sul terreno della creatività, che credevamo inviolabile?
Può essere la fine di una professione. O al contrario, se ben compreso il processo sociale e la tecnologia sottostante, la rinascita stessa del ruolo e del senso di essere architetti o urbanisti?
Potrebbe – è d’obbligo utilizzare il condizionale – essere una rinascita del ruolo se focalizziamo la nostra attenzione sul fatto che l’intelligenza artificiale:
- Solleva i progettisti dagli oneri meramente estetici o egocentrici e permette di concentrarsi sugli aspetti di senso e scopo dell’abitare; mettendo l’uomo al centro delle decisioni, il suo benessere e la sua felicità come cifra identitaria. Facendo assumere ad architetti e urbanisti il ruolo sociale, culturale ed economico che sino ad ora hanno deciso di abbandonare. Permettendo loro di essere costruttori di senso e di prospettiva, piuttosto che meri “instagrammatori” delle funzioni abitative.
- Consente una multidisciplinarietà sino ad ora non sostenibile economicamente né gestibile dal lato delle competenze: troppo vaste e variegate per essere portate a sintesi dal bagaglio culturale dei singoli progettisti.
- Permette di organizzare partecipazione e co-progettazione nelle scelte progettuali e, soprattutto, nella loro gestione successiva. Rendendo architetti e urbanisti “mastri concertatori” di una domanda dal basso che deve, con fatica, raccordarsi con gli interessi economici e politici.
- Non rende onerosa la gestione della complessità e dell’incertezza delle variazioni urbane e territoriali, elementi costanti del nostro tempo di turbolenze globali. Senza quindi contribuire ad acutizzare la polarizzazione conflittuale tra centro e periferia, tra “parchi a tema” gentrificati e “dormitori” terra di nessuno. Periferia oggi culla dei conflitti sociali, della violenza tra gang, dell’emarginazione delle fasce fragili della popolazione, sia giovanile che anziana.
- Consente anche ai piccoli studi di poter competere alla pari con i grandi, poiché permette di superare il blocco dei costi e dei tempi; andando così a valorizzare le nuove generazioni rispetto alle posizioni consolidate di vecchi maestri che spesso “bloccano” gli allievi invece che lavorare per il loro sviluppo.
Tutto bello quindi? Tutt’altro. Molti aspetti della IA sono in costante divenire e fuori dal nostro controllo. Soprattutto perché la tecnologia è in mano solo a poche società big-tech di matrice statunitense o cinese, che ne controllano la distribuzione e l’uso. Per non parlare di molti aspetti etici, di bias e di cybersicurezza che ne derivano.
Così come i modelli di addestramento dell’IA sono “piegati” sul mainstream, emarginando le storie e le culture locali, sia perché non presenti sul web o perché collocate al di fuori dello scintillio hollywoodiano dei dati e delle informazioni nei social.
Una responsabilità anche degli Ordini professionali
Cosa rimane perciò agli architetti? L’esser consapevoli di dover fare una scelta di campo, sicuramente costosa e di non facile soluzione. Poiché vorrebbe dire abbandonare l’ambizione da archistar perché le IA lo sanno fare meglio. E iniziare, invece, un percorso di rinascita di senso e di ruolo, le cui incognite sono tantissime e in continuo divenire.
Una scelta di campo che vede coinvolti anche gli Ordini professionali, che dovrebbero abbandonare il ruolo di meri notai formali della professione, puntando, invece, su quella ”intelligenza collettiva” che le IA non possiedono e che renderebbe la tecnologia funzionale all’uomo e non, come accade oggi, il contrario. Se gli Ordini debbono essere una corporazione – una “gilda” come soleva dirsi in tempi medioevali – allora la funzione di scudo protettivo deve essere verso il “capitale semantico” degli architetti, dei costruttori di senso dei luoghi e dell’abitare: e non, invece, sul recupero dei crediti di fatturazione o l’attestazione della partecipazione ai corsi di formazione.
Immagine di copertina: edificio realizzato dall’AI attraverso il semplice prompt “proponi un edificio per uffici contemporaneo, in città, con verde integrato”

Nato a Gallipoli (Lecce, 1965), laureato in architettura all’Università di Firenze nel 1992, ha conseguito un master presso il Dipartimento di Geo-informazione dell’Università di Vienna nel 1993, un dottorato di ricerca in Pianificazione all’Università La Sapienza di Roma nel 1998 e un post-dottorato presso il Dipartimento di Economia politica dell’Università di Siena nel 2006. È direttore della Cassa edile della provincia di Lecce, curatore di Smart Ark Academy e presidente dell’associazione culturale Eligere futuro