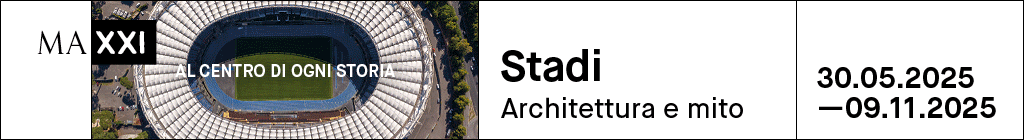Valle Cervo tra storia, pietra e tentativi di riscatto
Nel Biellese, un territorio alpino combatte lo spopolamento valorizzando il patrimonio storico e cercando nuove strade
Published 16 settembre 2024 – © riproduzione riservata
BIELLA. L’alta Valle Cervo, una terra di tradizioni secolari e paesaggi quasi incontaminati, racconta la storia di una comunità che ha saputo trasformare le difficoltà ambientali in risorse, attraverso l’arte della lavorazione della pietra e la condivisione sociale. Oggi, mentre affronta nuove sfide come lo spopolamento, la Valle cerca di reinventarsi, con progetti innovativi che guardano al passato per costruire un futuro sostenibile.
Biografia di una valle
L’alta Valle d’Andorno, conosciuta oggi come Valle del Cervo o Bürsch, è una regione montuosa del Biellese, ricca di boschi di castagni e faggi e attraversata dal torrente Cervo. Le alture che la circondano, con la punta del Bo come culmine a 2.556 metri, hanno modellato una valle dove l’uomo ha dovuto adattarsi a un ambiente severo. Sin dal XIII secolo è stata popolata grazie ai valichi che permettevano scambi con comunità di origine franco-provenzale e alemanna. L’economia locale, basata principalmente su allevamento e agricoltura, ha visto un progressivo declino dell’attività pastorale, compensato da emigrazioni stagionali che hanno portato nuove risorse e competenze.
La valle ha acquisito autonomia amministrativa nel 1694 con la nascita del comune (denominato Valle), suddiviso poi nel 1700 in quattro municipalità: Campiglia Cervo, San Paolo Cervo, Quittengo e Piedicavallo. Nel 1906 fu istituito il comune di Rosazza, mentre nel 2016 Campiglia Cervo assorbe San Paolo Cervo e Quittengo. L’emigrazione ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere l’economia della valle, permettendo la costruzione d’infrastrutture come strade, chiese e ponti, soprattutto durante il XVIII secolo.
Gli abitanti della Bürsch hanno sviluppato un modello sociale basato sulla condivisione delle risorse, con un uso collettivo della terra e una gestione comunitaria delle infrastrutture. Le abitazioni tradizionali integravano spazi per uomini e animali sotto lo stesso tetto, massimizzando l’efficienza del lavoro e preservando il suolo. Gli statuti locali regolavano l’utilizzo delle risorse, con progetti comunitari per edifici, strade e sistemi d’irrigazione, dimostrando un profondo legame tra gli abitanti e il loro territorio.
Storie di pietra
Un aspetto distintivo dell’alta valle è il suo legame con la lavorazione della sienite, un granito particolarmente resistente e apprezzato a livello internazionale. Con pochi pascoli e risorse agricole, la popolazione locale si specializzò nell’estrazione e lavorazione di questa pietra, che veniva utilizzata sia a livello locale che esportata all’estero: un mestiere, alternativo all’attività pastorale, che divenne fonte di sostentamento per molte famiglie. Nei secoli passati, la lavorazione della sienite ha reso celebri nel mondo le maestranze della Valle Cervo, con i pica-pere (gli scalpellini) che portavano la loro abilità anche all’estero, lavorando in grandi progetti architettonici come il Duomo di Milano. Il mestiere dello scalpellino-muratore, tradizionalmente praticato dai Valit (abitanti della valle), ha caratterizzato l’economia della zona fino alla metà del XX secolo. L’estrazione della sienite, iniziata a livello industriale intorno al 1830, raggiunse il suo apice ai primi del Novecento, con oltre 200 lavoratori impegnati nelle cave grazie alla costruzione della tramvia Biella-Balma.
La lavorazione della sienite, basata inizialmente su trovanti naturali, è stata regolamentata dal 1840 al 1979. Le amministrazioni locali hanno introdotto contratti e capitolati rigorosi per garantire la sicurezza pubblica e la realizzazione di opere utili alla comunità. Le cave comprendevano spazi per l’estrazione, lavorazione e stoccaggio della pietra, con edifici di servizio come fucine e magazzini. Il trasporto della sienite avveniva via carri verso Biella, da dove proseguiva per varie destinazioni internazionali. Tuttavia, col passare del tempo, le difficoltà economiche e ambientali portarono alla chiusura delle cave. Nonostante la cessazione dell’attività estrattiva, la pietra resta un elemento fondamentale nelle costruzioni locali, simbolo dell’ingegno e della capacità di adattamento degli abitanti della valle. Le opere d’ingegneria locale, come muri a secco, strutture anti-valanga, mulattiere e terrazzamenti per agricoltura e boschi, dimostrano la capacità di adattamento umano all’ambiente montano, trasformandolo in modo sostenibile.
La sienite è stata impiegata per la realizzazione di pavimentazioni stradali (cubetti, pavè), ma anche in manufatti di grande pregio, sia pubblici che privati. La prima opera di rilievo realizzata fu la colonna della basilica della Consolata di Torino, nel 1837, alta 7 metri. Sebbene nei giacimenti della Bürsch non fosse possibile estrarre blocchi monumentali paragonabili a quelli di altre località, nel 1879 dalle cave della Balma vennero ricavate quattro colonne di 8,45 metri di altezza e 1 metro di diametro, per il pronao della chiesa francese di Notre Dame de Fourvière a Lione. La lavorazione della pietra avveniva direttamente in loco, e il materiale di scarto veniva riversato nel torrente Cervo o nei terreni sottostanti il piazzale della cava.
Parallelamente all’estrazione della sienite, l’economia domestica e rurale della Bürsch era gestita prevalentemente dalle donne, mentre gli uomini emigravano in cerca di lavoro. Questo flusso, caratterizzato da una forte componente qualificata, ha permesso alle famiglie di mantenere un equilibrio economico. La costruzione delle Scuole tecniche professionali a Campiglia Cervo nel 1862 e a Rosazza nel 1869 ha contribuito a valorizzare ulteriormente le competenze dei lavoratori locali. Le scuole, incentrate su materie come geometria, matematica, disegno e tecniche costruttive, formarono migliaia di studenti fino alla chiusura nel 1975.
La valle oggi
Nel 2009 il Comune di San Paolo Cervo ha inaugurato il “Parco delle cave“, uno spazio ricreativo negli ex siti estrattivi che include una palestra di roccia, vie ferrate, aree picnic e sentieri panoramici. Questa trasformazione rappresenta un esempio di come la Valle abbia cercato di reinventarsi e valorizzare il proprio patrimonio storico e ambientale. Oggi, il mestiere dello scalpellino è quasi del tutto scomparso, con l’eccezione del laboratorio di Bogna (Quittengo), dove ancora si lavora la sienite.
La Valle Cervo, come molte altre aree montane italiane, affronta il problema dello spopolamento e della mancanza di servizi. Nonostante progetti pilota in altre zone montane italiane dimostrino che la rigenerazione è possibile, la rinascita di queste comunità richiede un impegno costante da parte delle istituzioni. Progetti come il recupero degli edifici storici, l’implementazione d’infrastrutture moderne e il potenziamento dei servizi possono aiutare a ridurre l’abbandono di queste aree, permettendo una nuova fase di crescita sostenibile.
A Rosazza, il 30 agosto scorso è stato presentato il cortometraggio, elaborato in realtà virtuale, dal titolo Storie di Pietra. La vita nell’alta Valle del Cervo, prodotto da ETT Spa in collaborazione con Equipe Arc en Ciel, diretto da Federico Basso. Il film offre un’esperienza immersiva a 360° tramite visori, mostrando la vita autoctona nel tardo Ottocento.
L’adozione di buone pratiche, il coinvolgimento attivo della comunità locale e una visione a lungo termine potrebbero rappresentare le soluzioni per affrontare le sfide future della Valle Cervo, mantenendo vivo il legame tra uomo e territorio.
Immagine copertina: foto storica delle cave di sienite della Balma, in alta Valle Cervo (© Fondazione Opera Pia Laicale Santuario di San Giovanni d’Andorno)
Dottorando in “Civil and Envirnmental Engineering” al Politecnico di Torino.
Precedentemente, ha conseguito la laurea magistrale in “Civil Engineering” presso il
Politecnico di Torino. Svolge attività di ricerca teorica e applicata nell'ambito del BIM,
GIS e Digital Twin, con particolare focus sulla prevenzione del dissesto idrogeologico in
aree montane con l’obiettivo di garantire la sicurezza di questi territori, preservandone
al contempo il patrimonio storico e culturale.